A Murphy
ti ricordiamo, sibling, e lottiamo affinché non avvenga più

È il 14 marzo del 2024. Siamo nell’aula magna dell’ospedale Molinette, Torino. Il Centro interdipartimentale disturbi identità di genere (Cidigem) sta presentando il nuovo percorso diagnostico terapeutico assistenziale. C’è appena stato un intervento dal pubblico: una donna ha chiesto conto della somministrazione di bloccanti alle persone trans adolescenti e dei danni permanenti che, lei dice, possono causare. Noi ci agitiamo sulla sedia.
Ora, mi fa comodo supporre che tu sia fra quelle persone che di identità di genere e di esperienza trans non sa nulla. Provo a prenderti per mano e a raccontarti alcune cose. Quando senti parlare di “bloccanti” in Italia si intende una molecola, la triptorelina. Il farmaco può essere usato per mettere in pausa lo sviluppo sessuale delle giovani persone che si stanno interrogando sul loro genere e dare loro la possibilità di prendere tempo e decidere con più calma se intraprendere un percorso di affermazione di genere medicalmente assistito. Si ha piena efficacia solo con una somministrazione tempestiva, all’inizio della fase puberale. Se dividiamo, come ha fatto James Tanner, lo sviluppo sessuale in una scala da 1 a 5, deve essere somministrato entro la fase 2, dopo può funzionare solo come coadiuvante di una terapia ormonale già avviata. La letteratura scientifica dichiara che gli effetti della molecola sono completamente reversibili: all’interruzione della somministrazione lo sviluppo riprende. Tuttavia “i bloccanti ai bambini” è il nuovo punto d’attacco e leitmotiv delle associazioni transnegative di tutto il mondo, incluse quelle italiane. L’intervento della persona che ha appena preso parola ne conserva tutto il lessico e le idiosincrasie.
Ci consultiamo brevemente fra noi e in batteria chiediamo alla dottoressa che sta rispondendo alla domanda di uscire dall’ambiguità, perché il punto ci pare un altro:
– Quante persone in carico all’ambulatorio varianza di genere gestito dalla neuropsichiatria infantile prendono la triptorelina?
– Sei persone.
– Sei persone su quante?
– Sono circa il 20%.
Una piccola percentuale, come pensavamo. Ma ci guardiamo con smarrimento: potrebbe essere addirittura un po’ gonfiata, trenta in totale è una cifra inferiore alle nostre stime. Ma questa è un’altra delle storture che circondano la vita delle persone trans: ci sono poche statistiche serie che ci riguardano. Per giunta, da anni il Cidigem, a dispetto delle continue richieste di associazioni, collettivi, assemblee – inclusa la nostra, Sei trans*? – rifiuta di rendere noti i suoi numeri.
Accanto a noi c’è Cecilia Ruiz Lopez dell’associazione Genderlens che chiede:
– Quante persone fra queste sei hanno cominciato i bloccanti entro la fase Tanner 2?
– Una.
Assaporiamo la sgradevole sensazione di quando le tue più pessimistiche supposizioni sono confermate. Se prendiamo per buoni i dati che ci vengono comunicati ora, a voce, solo un trentesimo delle persone in carico al servizio prende qualcosa che blocca davvero. È una conferma del nostro lavoro di indagine dal basso: la somministrazione di triptorelina in funzione di bloccante della pubertà – contrariamente agli allarmi delle associazioni transnegative – non è poi così diffusa in Italia e nella nostra regione men che meno. Più tardi ci pentiremo di non aver posto un’ulteriore domanda, questa:
– Si tratta dello stesso farmaco che viene prescritto alle piccole persone cis il cui sviluppo sessuale viene giudicato troppo esuberante e/o precoce?
Perché sì, la triptorelina è un composto che nasce per le esigenze delle persone (o di una certa mentalità) cisgender. In realtà, in Italia, nessuno dei farmaci ormonali è studiato per le esigenze della popolazione transgender, sono tutti prescritti off label, fuori dalle indicazioni terapeutiche previste, testosterone ed estrogeni inclusi. Comunque il punto ora è un altro: qualsiasi medico di base può prescrivere i bloccanti a una piccola persona cisgender, o supposta tale, senza nessuna valutazione psicologica. Quando invece a richiederli è una persona che infrange le norme di genere ci vuole un’equipe medica (completa di bioeticista) che ne valuti l’assoluta necessità, soppesi ogni affermazione e indaghi la veridicità della sofferenza. In caso contrario ci si straccia le vesti, si denunciano transizioni forzate, si addita la presunta teoria gender.
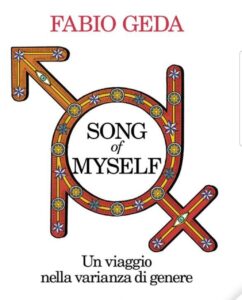 Parto da questo aneddoto per tracciare un ragionamento che prende le mosse dal recentissimo Song of myself. Un viaggio nella varianza di genere (Feltrinelli, 2024). Il nuovo libro di Fabio Geda rende materia narrativa un’osservazione in vitro condotta su alcune delle giovani persone trans che frequentano il reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale Regina Margherita di Torino, l’ambulatorio in cui chi ha meno di diciotto anni può cominciare il percorso di affermazione di genere. Ne esce un’opera scritta in maniera partecipata, accattivante, lastricata con le migliori intenzioni e ineccepibile per un pubblico ignaro di tutto ciò che concerne l’identità sessuale, come l’autore stesso confessa di sé. Solo che in questo pugno di pagine l’esperienza della dissidenza di genere resta schiacciata fra un’epistemologia patologizzante e una rappresentazione dolorosa a misura dell’ideologia straight. L’approccio è coloniale e la semplificazione estrema: Song of myself mette a rischio la comunità trans tutta e le persone più giovani in particolare.
Parto da questo aneddoto per tracciare un ragionamento che prende le mosse dal recentissimo Song of myself. Un viaggio nella varianza di genere (Feltrinelli, 2024). Il nuovo libro di Fabio Geda rende materia narrativa un’osservazione in vitro condotta su alcune delle giovani persone trans che frequentano il reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale Regina Margherita di Torino, l’ambulatorio in cui chi ha meno di diciotto anni può cominciare il percorso di affermazione di genere. Ne esce un’opera scritta in maniera partecipata, accattivante, lastricata con le migliori intenzioni e ineccepibile per un pubblico ignaro di tutto ciò che concerne l’identità sessuale, come l’autore stesso confessa di sé. Solo che in questo pugno di pagine l’esperienza della dissidenza di genere resta schiacciata fra un’epistemologia patologizzante e una rappresentazione dolorosa a misura dell’ideologia straight. L’approccio è coloniale e la semplificazione estrema: Song of myself mette a rischio la comunità trans tutta e le persone più giovani in particolare.
Un viaggio organizzato
Gli aspetti sottilmente problematici e più o meno direttamente dannosi sono molti e un intero libro non basterebbe a decostruirli: in questo spazio mi concentro solo su quelli più macroscopici. Iniziamo: fra le pagine del libro non è mai ben chiaro per quale fine Geda scriva di esperienza trans, né per quale ragione l’ambulatorio autorizzi e promuova l’iniziativa ma, soprattutto, l’autore manca di porsi una domanda fondamentale: perché queste giovani persone sono in ospedale? Se partiamo dall’assunto, come Geda afferma di fare, che quella trans è una delle possibili esperienze del genere umano, non una malattia, né un disturbo, per quale ragione queste persone adolescenti hanno bisogno di un centro medico dedicato? Non certo per i bloccanti, quelli – l’abbiamo visto – li potrebbe prescrivere un qualsiasi medico di base. E poi, a cascata, altre domande: se il viaggio è “nella varianza di genere” perché gran parte del libro riporta le voci dei genitori cis e delle neuropsichiatre del Regina Margherita, cis anche loro? E poi “varianza” rispetto a cosa? Chi trae vantaggio, e in che modo, da questo confine?
Da persona trans ho vissuto la lettura di Song of myself con estremo disagio, rabbia e un gigantesco senso di oppressione e claustrofobia. Il grosso della narrazione ha luogo in una stanza d’ospedale. Qui alcune delle persone trans prese in carico dalla struttura parlano e si raccontano “volontariamente”, sotto la supervisione di neuropsichiatre che stanno lì a prendere appunti. Si tratta di un setting tutt’altro che neutro. Ora, visto che Geda non lo fa, lo chiedo io a te che leggi: con quale serenità e quale grado di sincerità parleresti se delle professioniste della salute mentale che hanno nella tasca del camice le chiavi della tua autodeterminazione stessero lì a pesare ogni silenzio e ogni parola proferita?
Leo sta per diventare maggiorenne, è un ragazzo trans. Nei giorni in cui scrivo questa riflessione chiedo a lui e sua mamma, Ilaria, attivista di Genderlens, di vederci e parlare. È il venerdì di Pasqua, ci incontriamo in un bar di piazza Bengasi e mi raccontano il loro calvario alla neuropsichiatria infantile del Regina Margherita:
Leo: Guardavo le macchie [del test di Rorschach] e pensavo: ma se io dico che qua vedo una donna poi mi diranno che sono una donna? E poi mi facevano un sacco di domande per capire se provavo disforia per il mio corpo e io continuavo a chiedermi se c’era una risposta sbagliata o meno. Ovviamente è così: non c’è una risposta sbagliata. Una persona trans che non prova disforia ha gli stessi diritti di una che la prova. Comunque, in quella situazione devi capire se vuoi essere onesto, fedele a te stesso, e rischiare di metterci molto di più o se preferisci tagliare corto e mentire. Io non ho paura di ammetterlo: certe volte ho mentito.

All’interno della comunità trans sappiamo che chi ne ha capacità e/o possibilità confeziona la storia che il sapere medico richiede. Chi non ce la fa aspetta, si dispera o, se può, fugge altrove. Sandy Stone – attivista e pensatrice trans – già nel 1991 (ma riferendosi agli anni sessanta) scrive:
La clinica ha assunto il ruolo supplementare di “clinica per la cura della persona” o “scuola delle buone maniere” perché, secondo il parere del personale, gli uomini che si presentavano desiderosi di diventare donne non sempre si “comportavano come” delle donne. […] Il loro impegno come scuola di buone maniere era un tentativo volto a produrre non semplicemente femmine anatomicamente leggibili, ma donne, cioè femmine con un genere. […]. In pratica questo significava che i migliori candidati per l’intervento venivano valutati sulla base della loro capacità di performare il genere prescelto. […] Sorprendentemente, c’è voluto molto tempo – vari anni – affinché i ricercatori si rendessero conto che la ragione per cui i profili comportamentali dei candidati corrispondevano così bene a quelli delineati da [Harry] Benjamin era che anche i candidati avevano letto il libro di Benjamin, che era passato di mano in mano nella comunità transessuale, e che i candidati erano semplicemente molto felici di fornire un comportamento che li portasse a essere accettati per l’intervento. [L’“Impero” colpisce ancora: un manifesto post – transessuale in Canone inverso. Antologia di teoria queer, a cura di Elia Arfini e Cristian Lo Iacono, ETS, Pisa, 2012, traduzione di Barbara De Vivo]
Trent’anni dopo, Paul B. Preciado nel suo Sono un mostro che vi parla (Fandango, 2021) scrive:
Nel labirinto infinito delle istituzioni preposte alla verità di genere e sessuale ho avuto molti maestri […]. Ah, quando c’è da imparare, si impara; quando c’è da trovare una via di scampo, si impara in modo spietato!
Io stessa, per citare un esempio in contesto italiano, nel mio Senza titolo di viaggio (Alegre, 2021) teorizzo una “morfologia della fiaba trans”.
Se il genere ha un suo galateo e una sua ortopedia; se eterosessualità e identità fra sesso e genere sono naturalizzate come stato di salute e benessere; se la fenomenologia dell’incongruenza la scrivono le persone cis su basi binarie, stereotipiche e patriarcali, ecco che le persone trans si sforzano di mostrare buona educazione e buona volontà e, ovviamente, producono la storia che chi detta le regole del gioco è disposto ad ascoltare. Questa performance narrativa non è una specificità trans, è tattica comune di tutte le persone oppresse. Quando David Graeber scrive «le situazioni di violenza strutturale producono sempre strutture di identificazione immaginativa estremamente sbilanciate» [Burocrazia. Perché le regole ci perseguitano e perché ci rendono felici, Il Saggiatore, 2015] intende dire che mentre chi si trova in una posizione di potere può fare a meno di immedesimarsi, di mettersi in altri panni, di provare a intendere che situazione e che stati d’animo viva chi gli sta davanti, chi si trova in una posizione subordinata, e dipende dall’arbitrio di un potere esaminatore, deve impegnarsi in un continuo sforzo interpretativo: immaginare cosa passi nella testa dell’altro e, di volta in volta, congetturare quali cose di sé dire, come dirle e quali omettere. Magari è capitato persino a te: in un ufficio pubblico o a un posto di blocco per strada.
In nessun passaggio del suo libro Geda dà segno di essere consapevole dello squilibrio di potere in azione: da una parte persone adulte, cis, socialmente ed economicamente privilegiate, percepite come sane, in possesso di capitale culturale e dei titoli per spenderlo, dall’altra persone piccole e/o adolescenti, che infrangono le norme di genere, che danno segni di squilibrio mentale, che destano le preoccupazioni dei loro genitori.
Lo trovo molto grave e dannoso, ma voglio credere che non ci sia nessuna malafede. Mi pare più probabile che Geda si sia accontentato della narrazione medica che gli è stata fornita, senza interrogarsi sul suo privilegio e sulle conseguenze di utilizzarlo in maniera così superficiale.
Peculiare invece che problematizzi così poco l’esiguità del campione preso in esame. I centri dedicati ai “disturbi dell’identità di genere” sono meno di uno per regione. Alcune famiglie avviano le proprie creature direttamente alle terapie di conversione, altre – nel bene e nel male – la gestiscono in famiglia. Alle porte dei centri bussano adolescenti che hanno le risorse e/o si trovano in un contesto che consente loro di esplicitare l’esperienza che vivono o ci vengono portate quelle che disertano il genere in maniera troppo evidente e disturbante: un campione risicatissimo. Ma non basta, Geda lo confessa candidamente: agli incontri a cui partecipa, ascolta le voci solo di alcune delle persone presenti e, in ogni caso, non le può riportare fedelmente. La struttura sanitaria e i genitori delle persone in carico danno al famoso scrittore autorizzazione a carpire testimonianze, ma non a divulgarle nude e crude in un libro. Qui è l’unico passaggio in cui l’osservatore sembra avvertire la debolezza del suo lavoro:
Sento sempre più il bisogno di avere delle storie in cui scendere in profondità. Almeno tre, penso, anche se per abbracciare la complessità della varianza di genere ce ne vorrebbero molte di più.
Se mi chiedi di indicarti persone che possano raccontarti la mia storia è probabile che faccia i nomi di quelle che hanno di me una buona opinione. Se vuoi farti un’idea più complessiva ti conviene però cercare anche altrove, persone con cui sono entrata in conflitto o che hanno di me un pessimo ricordo. Geda però sceglie di continuare ad affidarsi solo alle neuropsichiatre del Regina Margherita: sono loro a segnalargli tre persone appena maggiorenni disponibili a condividere le loro storie. Si tratta di un ragazzo e una ragazza che raccontano esperienze plausibili tanto nella realtà quanto nel manuale di Harry Benjamin. La terza ha un posizionamento non binario, usa un pronome coerente con l’assegnazione alla nascita e non segue un percorso medicalizzato: l’eccezione che conferma la regola. Forse tre storie (e di così facile lettura), rinchiuse nella parentesi dello sguardo genitoriale e medico, sono un po’ poco per arrogarsi il diritto di sottotitolare “un viaggio nella varianza di genere”. Suona un po’ come pontificare su storia, politica e società del Nordafrica dopo una settimana a Sharm el – Sheikh.
Che cosa vedi? (senza lenti adeguate)
Geda ci dice che le giovani persone trans soffrono, che temono aggressioni, che tendono a far gruppo prevalentemente fra di loro. Nota come fino a qualche anno fa le uniche esperienze trans presenti nell’immaginario collettivo riguardassero persone con espressione di genere femminile, soubrette e/o sex worker. Si stupisce, e gli fanno eco le neuropsichiatre, che nell’ambulatorio del Regina Margherita arrivino soprattutto persone assegnate femmina alla nascita. Ognuna di queste osservazioni rimane senza spiegazione, chiusa in un guscio pre-politico, senza relazione con l’ostilità del contesto e l’azione dello stigma. Chiaro quindi che l’attenzione si concentri tutta sulla persona e la sua sofferenza.
Di nuovo, non credo si tratti di malafede e, in questo caso, nemmeno di superficialità. Se hai un microscopio difficilmente inquadri le stelle, se hai un telescopio ti verrà male analizzare una cellula. La parola “femminismo” in Song of myself ha zero occorrenze: non è un caso, è solo la conferma che Geda non usa quegli strumenti teorici. Per questa ragione in qualche punto scambia sesso e genere, per questa ragione non sa leggere il genere come dispositivo di relazione e gerarchia, per questa ragione ha difficoltà a capire come la pressione patriarcale opera in maniera diversa sulle persone trans a seconda della loro assegnazione alla nascita, per questa ragione manca di trovare tratti in comune fra la disforia che possono provare le persone trans con quella che possono provare le persone grasse, non rispondenti ai canoni estetici o con corpi fuori norma.

È proprio un peccato perché i femminismi gli avrebbero offerto almeno tre vie lungo le quali condurre riflessioni e narrazioni. La prima: le persone trans come elemento perturbante nella piramide delle gerarchie di genere; la seconda: il controllo dei corpi in atto su chi non è bianco–uomo–cis–etero–abbiente–abile; la terza: la transnegatività come una particolare forma di misoginia: tagliando con l’accetta, gli uomini trans sono troppo poco femminili e le donne trans lo sono troppo. Geda manca tutte queste occasioni e sceglie una lettura da una parte pietistica – “creature infelici, stanno male, aiutiamole” – e dall’altra culturale – “eh, che vuoi farci, la gente è ignorante”. Nessun cenno esplicito all’oppressione eterocispatriarcale, né alla transnegatività di stato, né alla particolare violenza medica che investe le persone trans; nessun argomento che metta al riparo dagli strali dei primitivisti indignati per l’artificiosità del corpo trans, né da quelli dei fondamentalisti cattolici scandalizzati da chi si sottrae al naturale progetto di dio, né da quelli scagliati dalle FART/TERF, quelle frange borghesi, elitarie, transnegative che additano gli uomini trans come traditrici, le donne trans come usurpatori e le persone non binarie come folli.
L’approccio di Song of myself si rivela del tutto inefficace a dare strumenti di riflessione alle persone cis, priva le persone trans di agency e, con la sua narrazione lacrimevole, le riconduce al solito trabocchetto coloniale dell’elemosina che conferma le élite e le subordinazioni.
Quello che Geda non dice
Fin qui mi sono soffermata sui limiti di impostazione e ho sempre tenuto alta la fiaccola della buona fede, da qui in avanti mi inoltro in quelle che temo siano deliberate omissioni.
Geda, benché faccia cenno a relazioni, giudici, tribunali, nulla osta agli interventi chirurgici, evita di menzionare la legge 164 del 1982 che, a determinate condizioni, permette alle persone trans di cambiare nome e genere sui documenti e di accedere alla chirurgia. Si tratta di una mancanza grave, come se volessi parlare di persone migranti oggi senza menzionare il reato di clandestinità. La legge 164/1982 orienta l’operato delle istituzioni e delle strutture mediche e contribuisce in maniera importante all’ostilità del contesto nei confronti di chi diserta i dogmi dell’assegnazione di genere. La premessa doverosa è che quella legge – retriva, binaria, violenta – era frutto delle lotte della comunità trans: depenalizzava condotte che fino a quel momento erano considerate reato, in primis gli interventi di riassegnazione del sesso compiuti all’estero. Quarantadue anni fa, certamente, era sentita come una vittoria. Ma non ci si può fermare qui. Oggi, ad esempio, le terf italiane chiedono che si torni all’interpretazione più restrittiva della legge, quella in cui un tribunale riconosce nome e genere solo dopo aver autorizzato le operazioni chirurgiche demolitive delle gonadi. Obbligo di intervento che dal 2015 è aggirabile grazie a due sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale e che, da allora, ha permesso a molte persone trans di evitare chirurgie indesiderate. La 164/1982, al di là delle intenzioni di quell’attivismo trans che quattro decenni fa ne richiese l’istituzione, è a guardia dell’ordine eterocispatriarcale costituito. L’altro aspetto su cui è esplicita, ad esempio, è che in Italia non esiste un matrimonio omosessuale, le unioni contratte in precedenza vengono sciolte ipso facto all’atto del cambio di genere sui documenti. E poi ci sono ancora due importanti aspetti sottintesi: la certezza del genere, uomo o donna, un terzo genere non è dato e, infine, l’irreversibilità del percorso. A questo punto possiamo rispondere a una delle domande precedentemente poste: a cosa serve quella manciata di centri dedicati ai percorsi di affermazione di genere? Non certo o non solo a tutelare la salute trans. Svolgono la funzione di ente certificatore, servono a selezionare e scremare le persone che possono presentarsi davanti al giudice con le carte in regola. Solo riconoscendo la funzione filtro svolta da alcuni centri di salute trans si comprende la ragione delle interminabili attese.
Leo: A Torino ho fatto decine di sedute. C’è stato un periodo di sei o sette mesi in cui ci andavo settimanalmente. Non avevo nessuna voglia. Mi sottoponevo a questa fatica solo per arrivare alla fine del percorso. Chiariamoci: non trovo che sia un percorso divertente, ma io vorrei sentirmi felice per ogni tappa che faccio, non voglio sentirmi angosciato, né obbligato a farlo per raggiungere un fine.
I centri devono accertare la disforia: alle persone trans è quindi richiesto di manifestare una moderata sofferenza psichica, ché troppa o troppo poca destano sospetto. Si tratta di un arbitrio che non ha nessuna ragione medica e che si spiega solo se si riconosce ai centri un ruolo normativo nei confronti della legge.
Leo: Immagina una persona minorenne che va lì. Ti senti tanto tanto tanto invalidato da tutti questi test. Ti fanno sentire matto. Perché devi farmi dei test psichiatrici per trovare una patologia se questa non è una patologia? Per diagnosticare la disforia di genere?! E poi, anche se avessi del disagio, ci sono molte possibilità che se ostacoli il mio riconoscimento e ritardi la prescrizione degli ormoni il mio disagio cresca. Come puoi curare qualcosa che è conseguenza del tuo agire di medico? Ti concentri sul sintomo e ignori la causa della sofferenza.
Persino la determina dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) dice che si possono prescrivere farmaci ormonali in presenza di una diagnosi di incongruenza di genere, la disforia non è necessaria. E, un passo oltre, nell’ottava edizione delle indicazioni stilate dalla World Professional Association for Transgender Health – nominalmente accolte da diversi centri italiani – è scritto esplicitamente che la presenza di disturbi di natura psichica non è una ragione sufficiente a ritardare il momento della somministrazione e che è scientificamente provato che supportare i percorsi di autodeterminazione migliora salute e benessere delle persone trans.
Anche alcune delle persone a cui Geda dà voce lo esplicitano: prima degli ormoni e prima delle relazioni da presentare in tribunale c’è un lungo processo per arrivare a una diagnosi differenziale che certifichi che la persona è davvero trans, che è disforica, che non sta mentendo o non si sta confondendo, dopodiché qualsiasi segno di disagio e di squilibrio deve essere preventivamente trattato in maniera da “stabilizzare” la persona, dove “persona stabilizzata” significa, in definitiva, persona psichiatrizzata. Ma Geda non coglie mai l’occasione per criticare la procrastinazione, la diffidenza e la continua messa alla prova a cui sono sottoposte le persone trans.
Leo: Anche per la relazione. Mi hanno detto che non potevano farmi cominciare la terapia ormonale perché avevo ancora problemi d’ansia. Mia madre ha detto: “ok, affrontiamo l’ansia, ma nel frattempo andiamo avanti”. E loro: “Eh, ma noi non possiamo, siamo l’ambulatorio di varianza di genere, non ci occupiamo d’ansia.” Per cui secondo loro io dovevo andare dalla neuropsichiatra, parlare della mia ansia e risolverla, che è impossibile. Cioè, si può attenuare, e negli ultimi tre anni è un lavoro che ho già fatto. Tre anni fa ho smesso di andare a scuola per l’ansia, oggi ci vado tutti i giorni. Direi che la situazione è migliorata. Riesco a ordinare le pizze al telefono o a chiedere qualcosa al bar, cosa che prima non riuscivo a fare, ma certo non grazie al loro aiuto. Al Regina Margherita mi sono sentito tanto invalidato. Per quale ragione non posso prendere degli ormoni se ho l’ansia? L’ansia fa parte della mia vita. Ho imparato a conviverci, ho imparato a superarla, non capisco perché dovrebbe precludere una cosa così importante. Loro hanno detto, letteralmente, che questo disturbo d’ansia non poteva farci continuare. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Una o due volte dopo gli abbiamo detto addio.
Geda non solo manca di cogliere il carattere violento e normativo del suo luogo di osservazione, ma perde l’occasione di dare parola a quelle persone trans lasciate in stallo, poste sotto psicofarmaci o mandate in comunità terapeutica perché la loro performance di genere non è adeguata, la loro storia non è convincente, stanno troppo o troppo poco male.
Non può essere una svista, c’è qualcosa di deliberato. Come deliberata deve essere la scelta di omettere il sottotitolo dell’unico saggio scritto da una persona trans citato in Song of myself. Il titolo Sono un mostro che vi parla di Paul B. Preciado è incompleto senza: Relazione per un’accademia di psicoanalisti. Il libro contiene la conferenza che il filosofo avrebbe voluto pronunciare nel 2019 per le giornate internazionali dell’École de la cause freudienne:
Il […] discorso ha provocato un cataclisma. […] Quando ho chiesto alle istituzioni psicoanalitiche di assumersi la loro responsabilità di fronte all’attuale trasformazione dell’epistemologia sessuale e di genere, metà della sala ha ridacchiato, altri hanno urlato o mi hanno chiesto di andarmene. Una donna ha dichiarato, abbastanza ad alta voce perché riuscissi a sentirla dalla mia tribuna: “Non bisogna lasciarlo parlare, è Hitler”. L’altra metà della sala ha applaudito. Gli organizzatori mi hanno fatto presente che il mio tempo era scaduto, ho cercato di sbrigarmi, ho saltato qualche paragrafo, sono riuscito a leggere soltanto un quarto del discorso che avevo preparato.
L’esperienza trans diventa accettabile solo se patologizzata, inquadrata dall’alto in basso, normata, ricondotta nei binari dell’ideologia straight, spuntata del suo portato politico e dell’alone di dubbio che getta sulla naturalità del dispositivo di genere. Geda, pur avendo avuto la possibilità di accorgersene, tace e implicitamente dà sponda alla narrazione che Preciado e l’attivismo transfemminista strenuamente contrastano.
Chi può prendere parola e per dire cosa?
 Più su ho citato Sandy Stone, ma è un suggerimento che ho colto da una delle persone trans che sono parte della mia sfamiglia. A me, durante la lettura del libro di Geda è tornato in mente quello scritto breve in cui Frantz Fanon scrive che “il comportamento del nordafricano provoca spesso nel personale medico un atteggiamento di diffidenza verso la realtà della sua malattia” [La sindrome nordafricana in Frantz Fanon, Decolonizzare la follia. Scritti sulla psichiatria coloniale, Ombre corte, 2011]. La diffidenza di cui sono oggetto le persone trans non è solo implicitamente avallata, ma mi pare che serpeggi proprio fra le pagine di Song of myself. A un’analisi quantitativa le persone cis, incluso il myself autoriale, parlano molto di più delle persone trans e poi c’è il fatto che le voci trans sono come incorniciate da quelle cis che aprono e chiudono l’opera.
Più su ho citato Sandy Stone, ma è un suggerimento che ho colto da una delle persone trans che sono parte della mia sfamiglia. A me, durante la lettura del libro di Geda è tornato in mente quello scritto breve in cui Frantz Fanon scrive che “il comportamento del nordafricano provoca spesso nel personale medico un atteggiamento di diffidenza verso la realtà della sua malattia” [La sindrome nordafricana in Frantz Fanon, Decolonizzare la follia. Scritti sulla psichiatria coloniale, Ombre corte, 2011]. La diffidenza di cui sono oggetto le persone trans non è solo implicitamente avallata, ma mi pare che serpeggi proprio fra le pagine di Song of myself. A un’analisi quantitativa le persone cis, incluso il myself autoriale, parlano molto di più delle persone trans e poi c’è il fatto che le voci trans sono come incorniciate da quelle cis che aprono e chiudono l’opera.
Nemmeno la selezione delle voci cis è innocente, si poteva dare spazio ad altre narrazioni. Io per queste note ne ho sentito la necessità. Sull’onda dell’urgenza e organizzando il tutto con un paio di telefonate, oltre alla voce di Ilaria, la madre di Leo, ho potuto ascoltare anche Cecilia. Ci siamo incontrate per la prima volta un paio d’anni fa, quando si presentò a un’assemblea di Sei trans*? per conoscerci. Trascrivo qui alcuni passaggi di una lunga conversazione di qualche giorno fa:
Cecilia: Mi sono rivolta al Regina Margherita per la prima volta quando Ale aveva tre o quattro anni. Il fatto che già da prima avesse una predilezione per i giocattoli femminili e parlasse di sé al femminile non ci aveva messo in allarme. In famiglia avevamo accolto con serenità questo suo modo di manifestarsi. Le cose hanno preso un’altra piega quando Ale ha iniziato a sentire la correzione delle persone esterne alla famiglia. Ha reagito molto male quando qualcuno le ha detto che doveva parlare di sé al maschile. A quel punto ha iniziato a nascondere il pisellino e rifiutarsi di bere l’acqua. Né il pediatra, né la psicologa sapevano come gestire la situazione. E così, attraverso i consigli di altre persone, sono arrivata al Regina Margherita. […]
Una cosa che mi rendeva perplessa è che mi dicevano che dovevo supportare Ale, volergli bene e mi dicevano: se vuole giocare con le bambole, parlare di sé al femminile, vestirsi da principessa o truccarsi non c’è problema, ma può consentirglielo solo quando è a casa.Filo: Il modo migliore per creare dissociazione e comportamenti schizoidi!
Cecilia: Una volta Ale mi aveva chiesto di andare al carnevale dell’asilo con l’abito da principessa. Io ne avevo già parlato con le maestre e loro erano state estremamente accoglienti e anzi, ne avrebbero approfittato come di un momento educativo. Le neuropsichiatre invece mi hanno detto di no, che dovevo proteggerlo. Io me ne sono fregata e Ale ha partecipato alla festa a scuola e anche a casa di una sua amica in abiti da principessa: sprizzava letteralmente gioia. […]
Loro dicevano di seguire l’approccio olandese, watchful waiting, la vigile attesa, che consiste nel non intraprendere nessuna azione e aspettare.Filo: Che poi quell’attesa silente e non partecipe in realtà è un’azione anche quella.
Cecilia: Sì, ma secondo me non rispettano nemmeno quella indicazione. Comunque mi sono informata, nessuna struttura olandese applica davvero quell’approccio, lì anzi hanno un atteggiamento accogliente e decisamente più affermativo. Solo in alcuni centri italiani ho sentito parlare di vigile attesa. La neuropsichiatra dava basi scientifiche a questo orientamento citando uno studio che dimostrerebbe che l’80% delle creature come Ale desistono prima dell’adolescenza. […]
Secondo lei dovevo insegnare alla mia creatura a comportarsi da maschio, perché c’era un’ottima probabilità che abbandonasse i suoi comportamenti non maschili. Quell’articolo è contestato sia a livello metodologico sia come approccio. Ma io in quel momento le ho risposto in maniera molto poco accademica. Ho detto: “Ma se Ale è in quel 20% di persone che non desistono significa che gli stiamo fottendo l’infanzia.” A quel punto la psichiatra mi ha urlato in faccia che bisogna educare i bambini e che i no sono importanti. […]
Avevamo già rifiutato la presa in carico neuropsichiatrica e psicologica, mi pareva che Ale, in generale, stesse bene e non vedevo la necessità che, già a quell’età, tutte le settimane andasse in ospedale. La neuropsichiatra mi ha risposto: “Lei ora lo vede bene, ma prima o poi starà male.”
Poi in seguito Ale ha avuto dei momenti di malessere collegati alla pressione sociale e al giudizio, noi abbiamo deciso di appoggiarci a un musicoterapeuta che la ha aiutata a gestire questo tipo di frustrazione derivante dal minority stress. Ora fa prima media e mi pare che stia bene.
Sono rimasta in contatto con alcuni genitori incontrati all’ambulatorio. Effettivamente qualcuna delle loro creature ha desistito, per stanchezza e sfiducia, e altre sono passate in un calvario di perizie, rinvii, atti autolesionistici, ricoveri.
Qui di seguito un frammento della conversazione con Ilaria, madre di Leo
Ilaria: Quando mi hanno dato la relazione di Leo ero un po’ scioccata. Sono andata da sua sorella minore e le ho detto: “leggi e dimmi la prima cosa che noti”. E lei: “ma è scritta tutta al femminile!”.
Un’altra cosa che mi ha molto colpita è che hanno scritto: “la paziente presenta un pensiero magico.” Sono andata a chiedere che cosa intendessero, anche se già lo sospettavo. E loro: “Sua figlia pensa che facendo la transizione – perché non parlano di “affermazione” di genere – i suoi problemi psicologici spariranno e questo è un pensiero infantile, come quei treenni che pensano che arriva la fatina dei denti.” Io ho risposto: “ma scusate, possiamo ammettere che la sua ansia almeno in parte deriva dal fatto che da tre anni e mezzo nessuno qui lo riconosce per quello che è? E che anche le sue aspettative possono essere determinate da questo clima?”
Nei loro piani, dopo quella relazione, Leo avrebbe dovuto fare almeno altri sei mesi di quegli incontri a cui ha partecipato Geda e sarebbe dovuto tornare dalla neuropsichiatra territoriale a risolvere l’ansia. Noi abbiamo tenuto il piede in due scarpe finché al Careggi di Firenze non ci hanno dato via libera.
Non è un caso che l’ospedale Careggi nelle settimane scorse abbia ricevuto un’ispezione ministeriale sollecitata da un’interrogazione parlamentare del senatore Gasparri e caldeggiata da un cartello di associazioni antiabortiste e transnegative. L’ambulatorio fiorentino è una delle poche strutture pubbliche italiane che si sforza di utilizzare un approccio affermativo nei confronti delle persone trans. Ma il punto qui è un altro: le testimonianze che ho riportato sono solo alcune delle testimonianze cis possibili, altre Geda le avrebbe potute raccogliere con facilità usando l’associazione Genderlens come tramite. Ha scelto di non farlo. Forse perché invise a chi gli offriva il campo di ricerca o forse perché avrebbero potuto far insorgere domande di questo tipo: se il protocollo seguito è quello della “vigile attesa”, se si tengono a bada le paure di genitori spaventati dalla non conformità di genere delle loro creature con la prospettiva di una “guarigione”, se la prescrizione è quella di limitare i momenti in cui le persone piccole possono liberamente esprimersi per come si sentono a pochi momenti casalinghi e agli incontri in ospedale, se è necessario performare una sofferenza acuta il giusto da convincere, ma non troppo da destare il sospetto di una truffa, se il perimetro del genere è tracciato da persone che ne hanno un’idea binaria e stereotipata, se qualsiasi segno di disagio psichico allontana il momento dell’autodeterminazione e pone le persone a rischio di psichiatrizzazione, come facciamo a distinguere l’operato di questi centri da quelli in cui si praticano terapie di conversione?
Se Geda voleva esserci alleato, si è dimostrato un pessimo alleato, incapace di raccogliere il carattere strutturale della violenza e dello stigma di cui le persone trans sono oggetto.
Cosa chiediamo al mainstream
L’economia di mercato è capace di ingurgitare qualsiasi fenomeno e restituirlo defecato sotto forma di prodotto. Nemmeno le riflessioni e le mobilitazioni politiche più radicali e anticapitaliste sfuggono del tutto alla logica estrattivista: mentre i movimenti lottano, argomentano, decostruiscono, fondano immaginari, cercano sponde, contaminazione e alleanze, sono continuamente a rischio di strumentalizzazione. È accaduto e accade anche per la riflessione transfemminista: l’attenzione all’esperienza trans in questi anni è sicuramente aumentata e si sono moltiplicate le presenze, anche se si è dato spazio a un numero limitato di voci e di modalità di racconto e riflessione.
Case editrici di tutte le dimensioni e diversi orientamenti recentemente hanno pubblicato libri sul tema: nella maggior parte dei casi si tratta di manualetti e di memoir, opere che certamente hanno contribuito a una maggiore informazione sull’esperienza trans, anche se l’autentico lavoro sugli immaginari, a mio parere, l’hanno svolto teoria femminista e narrativa sci-fi, gli altri due generi che la comunità delle persone trans che scrivono produce con più entusiasmo, urgenza e incisività.
Il libro di Geda vive a cavallo fra le due vie che l’editoria mainstream incoraggia quando tocca questi temi. Song of myself, infatti, in un’impostazione da memoir – l’autore racconta la sua avventura nell’ambulatorio torinese – inserisce stralci da bignamino, masticature ormai prive di succo di storia delle comunità queer e critica del sistema sesso-genere. Ma non contesto a Geda di essersi messo al centro della narrazione, né il taglio divulgativo ed entry level che ha dato a Song of myself e nemmeno di essere l’ennesimo maschio cis che viene estrarre valore dall’esperienza trans.
Negli anni scorsi i suoi libri sono finiti nelle scuole, letture delle vacanze per studenti delle medie e delle superiori, la sua firma ha un alto potere pervasivo. Mi preoccupa il fatto che quest’opera – ha tutte le potenzialità per finire nelle mani di chi fa professione educativa e di persone giovani – sia portatrice di estrema semplificazione, aderenza totale alla narrazione patologizzante e pietistica e, con il suo approccio men che riformista, incapace di messa in discussione dello status quo. Contesto, in definitiva, l’irresponsabilità di Geda e dell’editore nel trattare temi complessi con questo grado di approssimazione.
Mi si potrebbe obiettare che da un’opera che ha per orizzonte un pubblico generalista e ambisce al massimo a fornire una prima infarinatura informativa non si può pretendere di più. Invece sì, io credo che si possa e per concludere queste note provo a dimostrarlo.
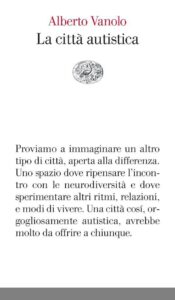 Poche settimane prima che uscisse il libro di Geda ha fatto la comparsa in libreria La città autistica (Einaudi, 2024) di Alberto Vanolo. L’autore racconta l’esperienza delle persone neurodivergenti con strumenti retorici del tutto simili a quelli scelti da Geda: aneddoti e scene di vita che danno sostanza emotiva a riflessioni e contestualizzazioni. Anche La città autistica è entry level ma, nonostante la schematicità, ha tutta un’altra profondità. Fin dal titolo si intuisce il passo diverso: Vanolo esegue la mossa di jujitsu di cambiare segno a termini stigmatizzanti, patologizzanti, dispregiativi: “autistico non va inteso in senso peggiorativo e la condizione di neurodiversità può offrire molto per progettare città più vivibili e più aperte”, scrive. Un’azione lontanissima dalla scelta di Geda che omette il termine “trans” in copertina e lo centellina per tutte le pagine del libro.
Poche settimane prima che uscisse il libro di Geda ha fatto la comparsa in libreria La città autistica (Einaudi, 2024) di Alberto Vanolo. L’autore racconta l’esperienza delle persone neurodivergenti con strumenti retorici del tutto simili a quelli scelti da Geda: aneddoti e scene di vita che danno sostanza emotiva a riflessioni e contestualizzazioni. Anche La città autistica è entry level ma, nonostante la schematicità, ha tutta un’altra profondità. Fin dal titolo si intuisce il passo diverso: Vanolo esegue la mossa di jujitsu di cambiare segno a termini stigmatizzanti, patologizzanti, dispregiativi: “autistico non va inteso in senso peggiorativo e la condizione di neurodiversità può offrire molto per progettare città più vivibili e più aperte”, scrive. Un’azione lontanissima dalla scelta di Geda che omette il termine “trans” in copertina e lo centellina per tutte le pagine del libro.
Dopodiché, come Geda, anche Vanolo prova a dare uno sguardo da dentro, e gli riesce di farlo senza il voyeurismo del primo, anche perché fin dall’inizio svela la motivazione che lo spinge a scrivere e l’obiettivo che si prefigge. L’autore – in quanto genitore e caregiver di una piccola persona autistica – dichiara di sentirsi parte della comunità neurodivergente. Sceglie un tono lieve, piano, ma lontano da quello crepuscolare dell’altro torinese, non disdegna qualche incursione nel picaresco, ma senza scadere nell’esotizzante di Song of myself. Scelte formali e di posizionamento che da sole rivelano La città autistica come l’azione di un potenziale alleato. Ma non basta.
Vanolo dimostra di aver letto e di saper padroneggiare la letteratura prodotta dalle persone non neurotipiche: sulla base di quelle riflessioni mette in critica il concetto di diagnosi, riconosce l’artificiosità del confine fra neurotipicità e neurodivergenza; fa propria la riflessione dei disability studies che disancora la disabilità dalla persona, punta a restituirle agency, la inserisce in un contesto di interdipendenza, possibilità di autodeterminazione e rivela il contesto sociale come disabilitante.
Vorrei che sia chiaro: non mi interessa fare a pezzi Geda e porre Vanolo su un piedistallo.
Entrambi i libri hanno tutte le carte in regola per raggiungere un pubblico ampio, al di fuori della bolla di persone che abitualmente leggono di femminismo, esperienza trans, critica all’abilismo, neurodivergenza. Mi sembra invece importante capire che utilizzo politico possiamo fare del contributo pop di questi due libri. Nel secondo Vanolo usa il suo privilegio, le sue competenze, gli strumenti della teoria femminista e dell’attivismo neurodivergente per avanzare proposte politiche riguardanti l’intera società: “una città così, orgogliosamente autistica, avrebbe molto da offrire a chiunque”. Anche laddove ci sono scelte lessicali o passaggi discutibili, mi pare che l’autore le abbia ponderate e lasci lo spazio per la critica politica, epistemologica e per il confronto.
Per contro, nella visione di Geda, non c’è nulla che possa essere discusso alla pari: le persone trans possono essere al massimo un accessorio liberal dell’ideologia straight. Vale ora e sempre l’assunto dell’attivismo antirazzista: se sei qui per “aiutarci” puoi stare a casa tua, se invece pensi che la nostra lotta migliori anche le tue condizioni di vita, siamo felici di averti con noi. Non ci serve il tuo pietismo, ma la tua rabbia.
In conclusione, Geda fa un riferimento abbastanza gratuito a Lettera a una professoressa di Don Milani, nel libro di Vanolo invece, con il suo appello alla queerness, si legge fra le righe che l’obbedienza non è più una virtù. E questo ha l’aspetto di un primo timido passo per la convergenza delle lotte.